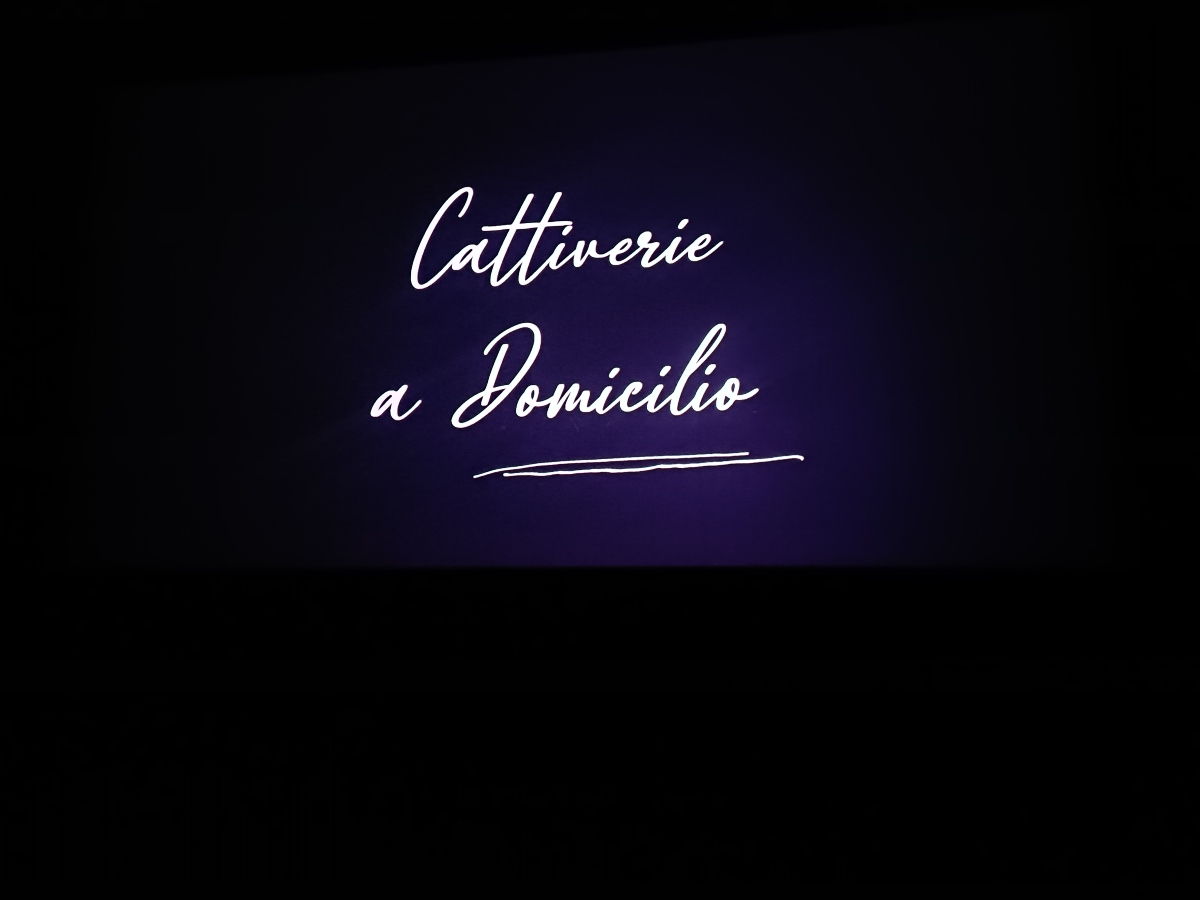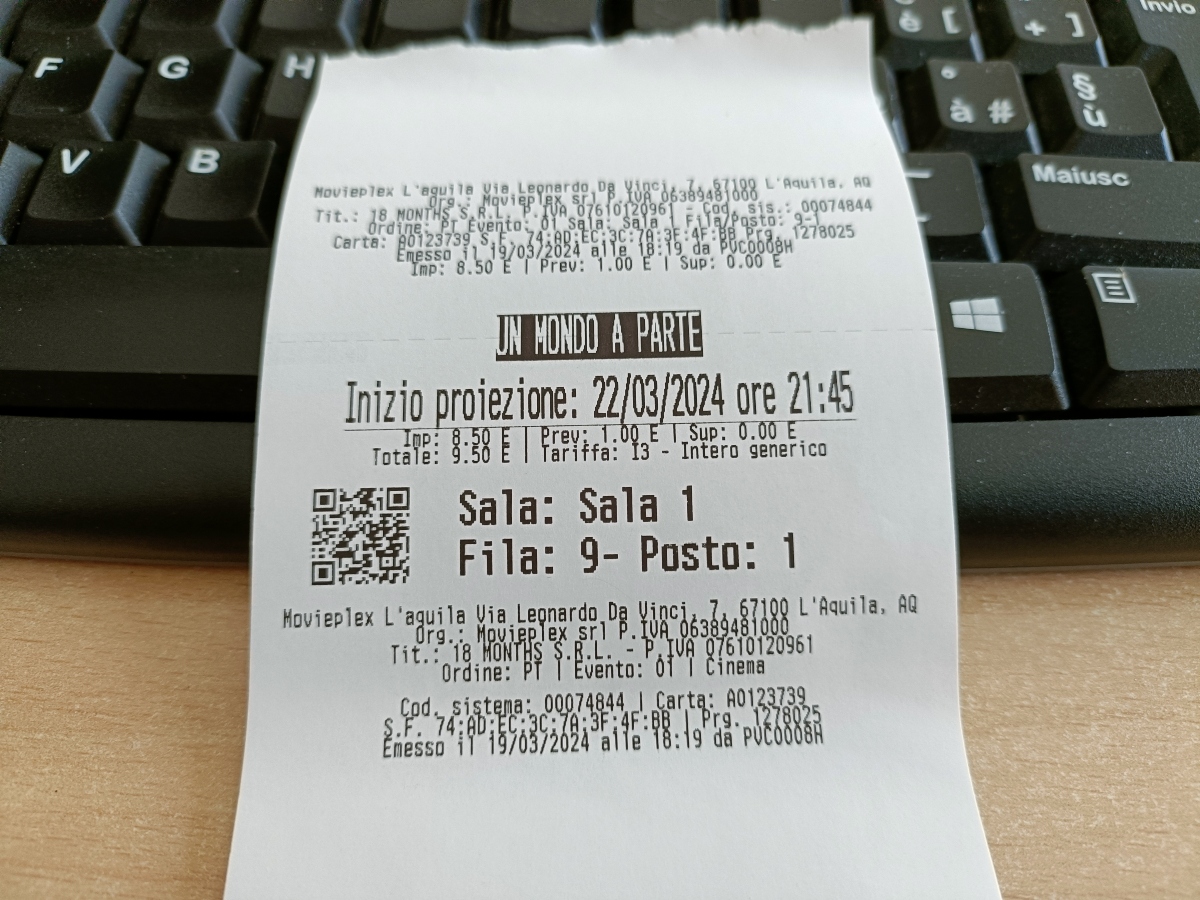La fotografia, credo sia, solo in parte, riproduzione della realtà.
In larga parte, è invece una possibile rappresentazione della realtà. Una inquadratura, taglia il mondo, e, con la luce, e le ombre, scrive, di per sé stessa una storia. Meglio, ne dà il tono, l’accento, la forma. La vista che la fotografia ci restituisce, è un modo di chiedere ai nostri occhi di guardare la realtà solo così; come ci viene rappresentata, e ci introduce nel mondo che una storia vuole raccontarci.
Il modo, con il quale Vittorio Storaro e la sua squadra di tecnici, con la sua fotografia, raccontano Parigi, in “Colpo di fortuna”, di Woody Allen, somiglia, esteriormente, al mondo nel quale il regista ambienta la sua storia.
E’ un mondo di altissima borghesia; di correttezza formale, di eleganza nei dettagli; di ricerca della bellezza e del massimo piacere nel vivere. Un mondo di simmetrie e di equilibrio, sulla superficie delle cose.
E, perciò, questa Parigi autunnale, colorata e morbida, luminosa, inizia a stridere, mentre la trama prende forma, con la sostanza stessa del racconto, come se il mondo nel quale la storia si svolge, camminasse in una direzione opposta a quel che i nostri occhi vedono; come se il regista volesse suggerirci, che la trama vera del vivere non è frutto di una armonia col mondo; ma di un suo contrasto continuo, profondo, irrisolto.
Ed è esattamente lo stesso tipo di contrasti che sono intrecciati nell’arco di tutto il racconto, tra chi pensa che la fortuna, la sorte, possa essere cercata e trovata, attraverso i propri atti e le proprie volizioni, e chi, invece, lascia che la propria vita scorra, muovendola in una direzione, piuttosto che in un’altra, a seconda di come il vento giri, senza che una propria scelta sia consapevolmente compiuta sino in fondo.
Ed è esattamente lo stesso tipo di contrasto che si trovi ad affrontare chiunque desideri interpretare il vivere: sempre sballottato dentro una doppia lettura possibile; da una parte la casualità assoluta degli eventi, che determina, volta per volta, le risposte dei protagonisti della storia, o del vivere; dall’altra, il concatenarsi degli eventi casuali, che, in realtà, pare rispondere ad un preciso disegno che produrrà una, ed una sola realtà finale possibile, che adombra persino un suo preciso messaggio morale.
Personalmente, riconosco alla vita un unico destino, che è quello di portarmi a morire.
E, personalmente, a tutti quelli che parlano di “destino”, non posso che augurare d’esser contenti nelle gabbie che si costruiscono; di trovare confortevole la loro assenza di libertà; di sentirsi bene accolti in un mondo che considera totalmente inutile la loro volontà, visto che tutte le decisioni, in presenza di un “destino” già scritto, sono state da tempo prese.
A tutti coloro i quali credono in un “destino”, chiederei molto umilmente di raccontarmi cosa mi accadrà domani. Se morirò; se avrò un incidente stradale, o se incontrerò l’amore della mia vita. Gradirei una risposta. Se non l’avessi, considererei ogni discussione chiusa, ma, sono consapevole che esista un’altra categoria di credenti nel “destino”: una categoria di persone molto più intelligenti e sensibili, o forse, solo molto furbe. Quelli che spiegano che il “destino” esiste, ma a noi non è dato conoscerlo. Che, in realtà, è un modo comodissimo, da una parte, per giustificare qualunque propria scelta, perché non di scelta si tratterebbe, ma di superiore volontà imposta dal “destino”; e, dall’altra, è uno stratagemma autoconsolatorio che si somministra a sé stessi per provare ad accettare il fatto che non possiamo controllare nulla, o quasi, del nostro vivere: ci diciamo che certi avvenimenti, specialmente quelli più tristi ed imprevedibili, sono frutto di un “destino”, e, con questo, forse, troviamo la forza di rassegnarci ad essi; forse consoliamo il nostro senso di colpa di sopravvissuti.
Woody Allen mette in scena una storia assai lieve, ma lo fa con una capacità di scrittura, e di dialogo, affilatissima; mai banale o scontata, e, nella quale, ogni snodo si presenta esattamente come potrebbe accadere in una vita reale, in cui noi procediamo, giorno per giorno, avendo in testa, e nel cuore, una serie di punti di riferimento; degli orientamenti che riteniamo fermi e saldi, e poi, invece, gli eventi ci fanno girare la testa e intraprendere direzioni diverse, con “naturalezza”, come se fosse, appunto, un “destino”, a farci compiere quelle scelte, rispetto alle quali, in realtà, avremmo avuto sempre a disposizione almeno due possibilità alternative tra loro. Così come, quegli stessi avvenimenti, avrebbero potuto essere, ma anche non essere.
Il risultato di questo andare ondivago tra le possibilità, è il nostro quotidiano ed incerto vivere, in cui scegliamo continuamente, le direzioni verso le quali ci muoviamo e rispetto al quale, siamo in balia della casualità.
“Dio non gioca a dadi con l’Universo”, secondo una notissima frase di Einstein, a suggerire che l’intero Universo, risponda ad una serie di leggi conoscibili; ma, dopo Einstein, la fisica quantistica, ha spiegato che il mondo è effetto di una serie di probabilità; la nostra stessa essenza ed esistenza, è solo una probabilità, in fondo.
Un Universo le cui leggi siano totalmente spiegabili e prevedibili, sarebbe un Universo privo di libertà; un Universo libero, è un Universo nel quale noi cerchiamo, costantemente, di aver nuove cose da dire per comprenderlo.
Un tempo, per dare una sterzata ad una storia, e condurla verso la fine che ci si proponeva, il teatro greco aveva inventato l’irruzione del Dio nella realtà: il “Deus ex machina”. Il Dio, con una “machina”, una attrezzatura di scena cioè, veniva calato nella vicenda, d’improvviso, senza che ve ne fosse l’attesa, e le sue parole, le sue azioni, la conducevano verso il finale che “ideologicamente” doveva avere: quel finale che aveva bisogno di un intervento giustificativo del Dio, per assolvere noi umani dalla fatica di scegliere, di assumerci una responsabilità.
Il “destino”, amministrato dal Dio, ci solleva dalla fatica di motivare coerentemente le nostre scelte, o di cercare giustificazioni alle nostre incoerenze, e salvo rari casi, ci assolve dalla fatica d’essere responsabili pienamente del nostro agire.
Nella storia di “Un colpo di fortuna”, non ci sono dei che intervengono; non ci sono destini che si manifestano e rendono chiaro che siamo solo delle marionette nelle mani di qualcuno nel nostro peregrinare sulla Terra. Ci sono le cose che avvengono, e le nostre umanissime risposte: fallaci spesso; deboli ed egoiste magari, o criminali, addirittura, e tutte attengono alla nostra umanità.
La mamma della protagonista sfida la trama interrogandola con la sua razionalità, ed è lei a condurla al suo finale, casuale. Casuale ma possibile, perché già accennato in alcune parole della storia, ma non inevitabile. Tutt’altro.
Ecco allora che in questa vicenda esile, Woody Allen proietta, un’altra volta ancora, la sua partita a scacchi con la morte, e con il senso del vivere.
Se vi fosse un Dio, o un “destino”, l’intera esistenza avrebbe un senso. Senza Dio, e senza “destino”, l’uomo deve accontentarsi di cercare un senso al proprio vivere, fino magari ad accorgersi, della sovrana indifferenza della realtà alle nostre sorti, che passano, e scolorano, e sull’acqua non lasciano traccia, come le leggere increspature, presto cessate, di un sasso che venga gettato in mare.
Così si vive, e così si può morire, mentre tutto procede per suo conto in direzioni per noi totalmente imprevedibili. In fondo, forse, noi umani non siamo preparati a questo. Abbiamo bisogno di narrazioni che giustifichino, che diano un fine, e non una fine qualsiasi al nostro essere.
Personalmente, lo comprendo; e certe volte, ho la tentazione d’abbandonarmi a questo fluire che mi protegga dalle mie scelte, o dal fare delle scelte.
Ma mi sembra di non aver assolto al mio umano compito.
Quello di provare a scrivere una storia, e a nasconderla nel cassetto segreto di una scrivania: potrebbe accadere che qualcuno la trovi, e comprenda la profonda ingiustizia del mio morire, e ne cerchi il colpevole. Però potrebbe anche accadere che la carta su cui ho scritto sia consumata dal tempo, senza che nessuno possa leggere le mie parole.
Il mondo, mio malgrado, andrebbe avanti lo stesso, persino se io pensassi d’essere l’artefice della mia fortuna, della mia sorte, del mio destino.
Tutte le storie, finiscono con una porta che si chiude sui nostri sogni. Io preferisco credere ai miei sogni, alla fisica quantistica della libertà, al caso.
Se mi sarò sbagliato, per paradosso, non sarebbe cambiato nulla, perché vorrebbe dire che era il mio destino, e che, io semplicemente mi sono ingannato.
Del che, fregherebbe a me solo.
Lunga vita all’omino con gli occhiali, e alla sua malinconia, così ricca d’amore per la vita.