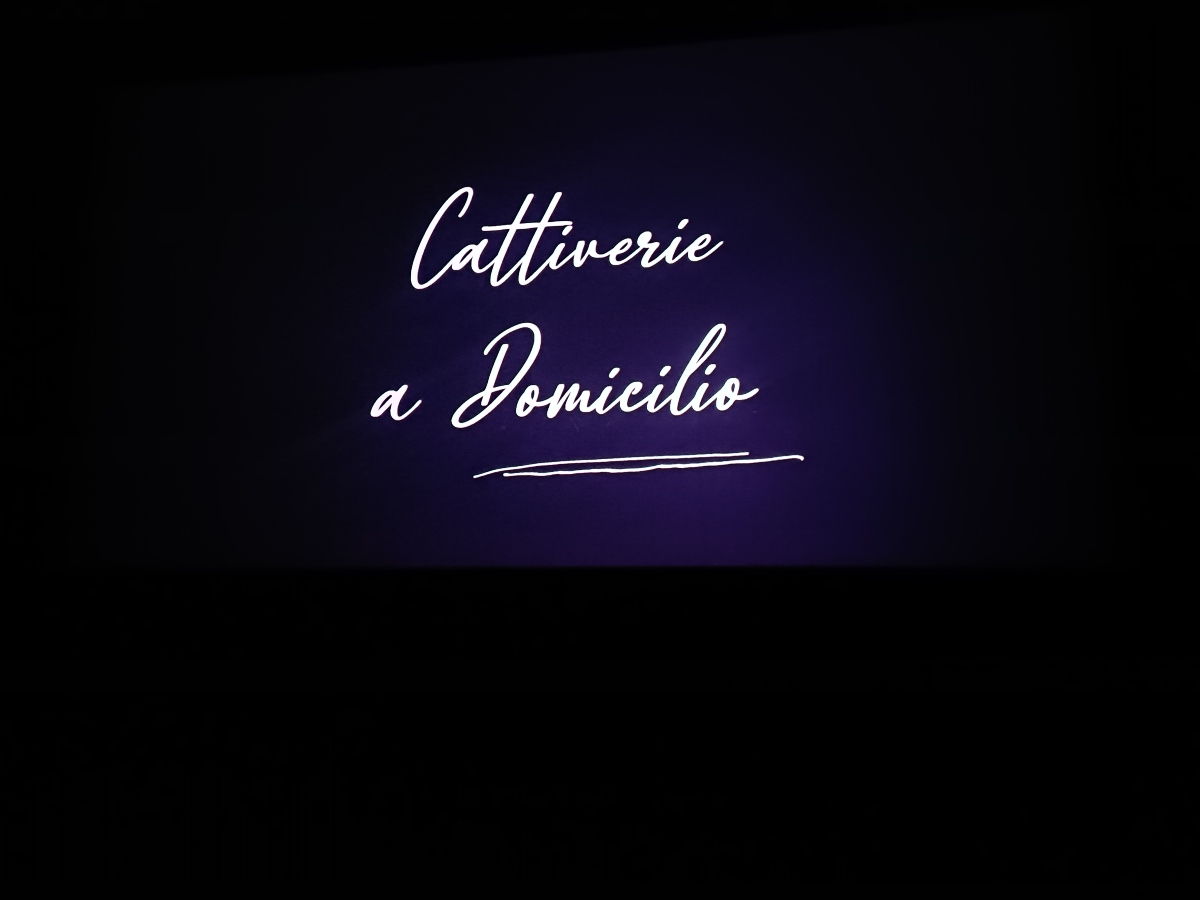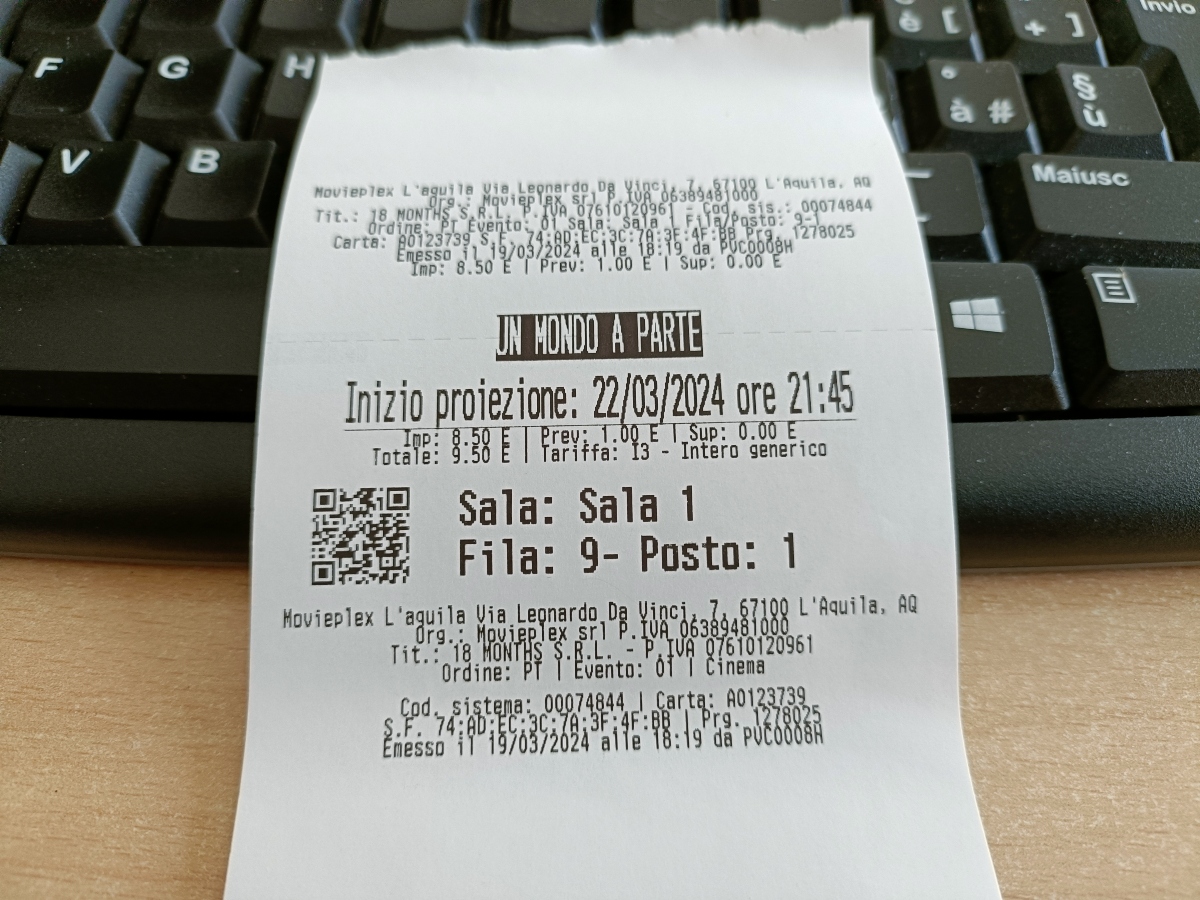A che cazzo serve, seppellire un cadavere, per di più senza nome ?
Al liceo gli studenti erano costretti a studiare per intero, “ I Sepolcri”, di Ugo Foscolo. Una poesia “civile”, che richiedeva uno sforzo interpretativo e di conoscenza, importante, ma, spesso, fissato dentro troppo schematiche tracce, risalenti a stantie accademie, da ripercorrere più o meno mnemonicamente, e freddamente, in sede di interrogazione. Per levarsi di dosso un peso fastidioso, gravato di italiano aulico, criptico, i cui rimandi letterari e culturali, facevano cenno ad un mondo non più vivo, e che avrebbe richiesto ben altra vivacità di sguardo, per essere compreso ed apprezzato da teste giovani.
Con un po’ di fortuna, allo studente restavano dentro la pietà, codificata come un dovere umano, verso i defunti; il legame, che la memoria è capace di creare, tra chi non è più, e chi è ancora, e la unicità della parola, anzi, della poesia, e quindi dell’arte, nell’abbattere le distanze temporali, ed eternare il ricordo di un nome, di gesta; del senso stesso del vivere.
All’ingresso dei moderni cimiteri, sulle cancellate, o sulle mura d’ingresso, sono incise, o scolpite, o poste in rilievo, frasi ammonitrici, che, in un giorno di sole, potremmo divertirci a considerare soltanto vagamente jettatorie, e non terribilmente realistiche, o evocatrici di una eternità, magari consolata dalla speranza religiosa.
Francesco Paolucci, decide, nel suo ultimo documentario, presentato ieri al palazzetto dei Nobili, nell’ambito del Festival delle Culture ad Aquila, di saltare, le spiegazioni, gli antefatti, le conseguenze, le considerazioni generali, e di metterci davanti ad una storia.
Una storia che racconta i bandoni di lamiera ondulata e rugginosa, che separano tra loro le strade interne di un cimitero; il cimitero vecchio di Lampedusa. Nudo, e seccato da un sole che asciuga persino le pale dei fichi d’India; e nel quale i fiori, e le piante, poste ad ornamento delle tombe, s’inaridiscono e s’inselvaggiscono rapidamente, scolorandosi, come i nomi sulle lapidi, come i carretti dalle ruote sbilenche e sgonfie, che dovrebbero raccogliere i residui polverosi delle visite dei vivi.
E, il raccontare una storia, servendosi quasi solo delle immagini, innanzitutto, significa in realtà aver molto pensato, prima, a cosa raccogliere, in fase di montaggio, di tutto il girato, e perché raccoglierne una parte e con quali fili, tenerla unita. Non è una operazione neutrale, per quanto la essenzialità delle immagini e del racconto farebbe supporre. Ma è un modo, forte, di dimostrare rispetto, verso la materia che si narra, e verso chi guardi, consentendogli di vagare in quel paesaggio senza ombre e disordinato, liberamente, ma non casualmente; consentendogli di pensare, e di farsi risvegliare dalle parole che ascolta, sempre poste fuori campo, e non direttamente pronunciate dalle persone, come se non contasse, chi parli, ma quel che si dice e si racconta, concentrando ancor più l’emozione e la tensione drammatica, senza farla distrarre dai volti che, quando sono inquadrati, come accade all’artista, egli stesso un migrante che ha traversato il mare, diventano un elemento del paesaggio, anch’essi bruciati dalla violenza del sole e dal sale delle onde, e dalla crudezza di quel che hanno per le mani.
La luce; la luce del sole, e del mare, e delle murature calcinate di bianco e crepe di tempo, contrasta col mistero oscuro, di storie senza volto, e senza neppure un nome, spesso; persone salite su un legno dal fasciame sconnesso, che non li ha protetti nel viaggio, terminato per loro non sulle coste del mercato comune europeo, ma nella notte eterna “in die illa tremenda”. E da lì, recuperati nelle loro spoglie mortali e interrati senza identità in quel cimitero in un’isola spersa di fronte alle coste d’Africa. Pura materialità da smaltire.
Dov’è la “corrispondenza d’amorosi sensi”, divina capacità umana di traversare il tempo e sconfiggere financo il buio della tomba, attraverso le mani e i ricordi, che si tendono verso un amico, verso un affetto ?
Magari è nelle dita di qualcuno che, per lasciare una testimonianza che dia un qualche senso a quella fine incomprensibile, traccia sulla calce ancora umida del fosso ricoperto, la parola che sottintende un intero mondo: “extracomunitaria”, appunto: non facente parte del mercato comune europeo. Una definizione per negazione, ma una identificazione almeno, se non altro, per quello che una persona non è, non è mai stata; non è mai riuscita ad essere: una cittadina dell’unico luogo che oggi riconosciamo. Il mercato.
Anche loro, che sono morti in mare, come noi, – potremmo pensare nel massimo del tentativo di identificazione che ci è concesso dalla civiltà del consumo – avrebbero voluto essere seduti a tavola, la sera, in attesa di consumare la cena, e ascoltare dal telegiornale, l’ennesimo trafiletto sui migranti senza volto, e senza nome, affogati annaspando nel Mare Nostrum, come lo chiamavano i nostri antenati dell’antica Roma.
Ora, questo mare, non è più nostro, ma è solo fastidiosamente percorribile da loro, senza volto, e senza nome. Marea povera.
Anche loro, come noi, avrebbero chiesto di cambiare canale, per non rovinarsi la digestione.
Perchè, purtroppo, una delle risposte possibili alla domanda che si pone una delle voci del documentario, su quale possa essere il modo che aiuti a comprendere davvero quel che accade da anni in quel braccio di mare, per porvi rimedio, è che spesso si comprende soltanto qualcosa che sia vicino alla nostra esperienza. E la nostra esperienza, da tanto tempo, troppo spesso, è l’egoismo, o il bene esibito. E’ il consumo, e non l’attenzione e la cura. E’ l’indifferenza, intesa come assenza di sensibilità, e autenticità, innanzitutto.
La Storia, la fanno i re, le regine, i condottieri e i tiranni. Le persone senza volto, e senza nome, che sono calpestate dalla Storia, finiscono nelle fosse comuni.
Le tante, troppe, infinite fosse comuni della nostra storia, e della nostra quotidianità.
Allora, forse, la parola, la poesia, l’arte, può provare a riscattare la morte inutile, lo spreco di preziosa vita.
Ed è un’arte di colori, quella di Modou Lamin, gambiano, raccontata dal documentario, che rompe il bianco del cimitero e segnala una presenza umana. Un dolore. Un desiderio che, nonostante la morte, non si spegne. Una ribellione, al tempo che polverizzerà tutto, e alla sordità dei nostri stomaci pieni.
Il lavoro di Francesco Paolucci, e di tutti quelli che hanno collaborato con lui, non pretende di offrire risposte, o teorie, semmai indica, sommessamente, liricamente, un punto di partenza: il riconoscimento dell’esistenza di esseri umani come noi, e cui, come a noi, il mercato non offre risposte, ma solo le egoistiche compatibilità economiche del profitto di pochi, anche sul piano politico, lucrato sulla paura di tanti.
La paura, nasce essenzialmente dall’assenza di conoscenza, e, allora, un altro tentativo di risposta a quella domanda – cui nel documentario segue solo il silenzio – riguarda la necessità di diffondere conoscenza.
L’inquadratura, ad un certo punto, pare staccarsi dal suolo ed allontanarsi verso il cielo, come se fossero gli occhi dei morti a guardare le mani dell’artista e dei volontari che, per la prima volta, danno sepoltura ai loro corpi, come se, ancora una volta, Antigone decidesse di violare la legge della vendetta e della superbia e continuasse a voler dare umanità ad un povero involucro spogliato anche dei suoi sogni.
Perchè si sia umani, bisogna testimoniare, la propria umanità.
Prima ancora di studiare strategie geopolitiche ed economiche.
Altrimenti, si diventa come quei quattro assenti al governo, che delle persone in mare, ne fanno solo ostaggio per il proprio interesse propagandistico.
Magari, un giorno, toccherà a loro, essere in mare, e pregare per un porto sicuro; allora, si augureranno di non incontrarsi.
Grazie, Francesco, che hai scosso un po’ la comoda abitudine dei nostri pensieri pigri.